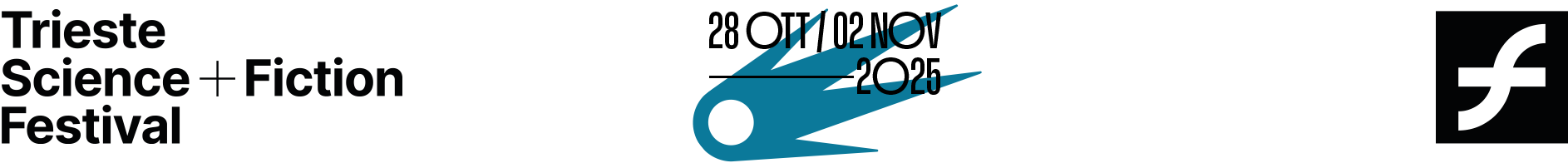“L’ultima stanza del mondo – Seconda parte” di Alex Tonelli
L’aria è gelida, stranamente densa. Il freddo arriva dritto alle ossa, schiacciandole. Le mani si fanno di pietra e le dita perdono la sensibilità, tanto che gli oggetti si trasformano in forme dipinte, senza spessore. Gli occhi lacrimano e piccole perle salate attraversano i volti, rigandoli in sentieri neri e tortuosi. Irriconosciuti marchi di guerra prima di una battaglia perduta.
Ma l’aria è densa. Spessa. Consistente come in un pomeriggio afoso. Solida come un brodo, pullulante di vita.
Faticosamente gli arti, stanchi e disillusi, si muovono in essa. Si spostano. Si agitano. C’è una antica fatica nelle membra delle figure sedute sulle poltrone. Un’indolenza che le lascia giacere. Immobili e in eterna attesa.
Ma nell’aria c’è forse qualcosa. Che vive. Prolifera. Si moltiplica. E uccide.
Invisibile nelle sue forme infinitesimali ma così numeroso da essere quasi solido. Denso nell’aria. Non ha un nome. Nessuno ne ha mai dato un nome. Se non il semplice. Tautologico. La Malattia.
E la Malattia è nell’aria. E nei polmoni. E nel sangue. E sulla pelle. Nelle quattro figure che siedono. E aspettano. Forse solo la fine.
– Non penso alla morte. Ma a volte ho l’impressione che la morte pensi a me.
Nel buio e nell’alone luminoso della lampadina le parole si muovono lente. Sembra che a fatica attraversino lo spazio che resta stranamente compatto. Lunghi secondi per giungere alle altre figure. Per essere comprese. Pensate e risposte.
– Ha ben altro da fare la morte per pensare a te.
– O a noi.
– E cosa avrebbe di tanto importante da fare?
Si ripete il gioco. Il bizzarro meccanismo. Affermazioni e domande. Cinismo crescente. Opprimente. Annichilente.
– Se ne starà in una limousine a bere champagne con la sua diletta.
– Vuoi dire?
– Si. Quella.
– La Malattia.
Il nome che non è un nome. Il nome che è la descrizione. Il nome che racchiude in sé tutti gli altri nomi. Il nome che è l’universale.
Il nome della paura. E della morte.
– Hai ancora le macchie?
– Si.
– Dove?
– Non lo so, non le vedo.
– Senti dolore?
– No. Non sento male. Ma le sento.
– Che intendi?
– Le sento sulla pelle, passandoci la mano. Sono quasi setose, molli, rotonde. Le sento in rilievo. Calde. Mi sembrano pulsare.
– Come se fossero vive.
Un colpo di tosse. Rauco. Lungo.
– Sono vive.
– Sono solo macchie.
– No! Non sono solo macchie. E’ la Malattia.
– Tutti l’abbiamo.
– Si.
– E siamo qui dentro per questa ragione. Perché siamo malati?
– Rinchiusi.
Nessuno parla più. L’ultima parola aleggia nell’aria. Ristagna. Danza nel vuoto colloso, melliflua. Sembra non voler andarsene e restare. Mormorando se stessa infinite volte.
– Rinchiusi.
– Da dove arriva?
– Cosa? La Malattia?
– Dov’è?
– Quando? Ora?
– Tutti abbiamo le macchie?
– Si. Sulle mani.
– Si. Sul viso.
– Si. Sul torace.
– Si. Sulle gambe.
Vi è una crudele pietà nel buio che serpeggia nella stanza. Un’oscurità che è una maschera. In cui nascondersi. Rifugiarsi. Celare agli occhi del mondo lo scempio. E il dolore. Delle macchie. Nere.
– Guariremo?
– Gli altri sono guariti?
– Chi sono gli altri?
– Che vuoi dire?
– C’è stato qualcun altro oltre noi?
– Nella stanza?
– Nel mondo?
– Altri sono stati malati?
– Altri?
– No. Nessuno è guarito. Credo.
– Lo credo o lo sai.
– Lo credo.
– Quindi c’è speranza.
– Si. Qui dentro si.
– Perché qui dentro.
– Perché finchè la porta non sarà aperta noi saremo vivi e morti. Contemporaneamente.
– Quale porta?
– Quella!
– Non c’è nessuna porta!
– Non abbiamo già fatto questo discorso?
– Ieri.
– O era un mese fa?
– Non era pochi minuti fa?
Il tempo si dilata e si deforma e ogni cosa acquista un senso nuovo. Relativo. Solo nel singolo uomo vi è la ragione di un’esistenza in sé assurda. Semplicemente insensata.
– Loro ci salveranno.
– Loro…
– Le ombre nel buio?
– Loro?! Loro non sanno neppure se siamo vivi o morti.
– Loro sanno tutto!
– Loro sanno solo che in questo momento, dentro questa stanza noi siamo al tempo stesso vivi e morti. E finché non apriranno la porta che non esiste noi resteremo in questo stato sospeso. Duplice. Eternamente vivi. Eternamente morti.
– Mi ricorda una vecchia favola.
– Si. Anche a me.
– L’ascoltavo da bambina.
– Raccontamela ti prego.
– Non la ricordo bene.
– Raccontagliela.
– Parlava di una scatola.
– O una gabbia?
– E di un veleno.
– Non era un atomo?
– Di uno scienziato
– Ma non era un filosofo?
– Ricordo che però parlava soprattutto di qualcos’altro.
– Di un gatto.
– Si, di un gatto.
– Che viveva.
– O che moriva?
– O forse entrambi?
Un ronzio. Appare e scompare nell’aria fredda della sera. Di un’identica sera. Sale e scende, s’allontana e s’avvicina, sino ad infastidire, urtare. Sino ad insinuarsi, malizioso, negli incavi delle orecchie. Violandoli. Brusio solleticante.
È trattenuto a fatica un gesto brusco, uno scatto convulso. Per scacciarlo. E le quattro figure se ne stanno sedute ad ascoltare. Ed osservare.
La piccola mosca ondeggia in spire ripetute, in spirali via via più strette, verso la lampadina che pende desolata dal soffitto. Nuota nell’alone di luce che debole si estende nello spazio oscurato della stanza, in una danza rituale verso la fonte, verso l’abbagliante chiarore che acceca. Verso il calore mortale della lampadina incandescente.
Un ronzio. Ogni suo movimento, ogni suo lento incedere è accompagnato da un frusciare, improvviso, senza ordine, come guidato da una casualità a cui essa stessa non riesce a dare una spiegazione.
La mosca vola, a tratti s’ode il brusio delle sue ali e incantate le figure sedute sulle poltrone spaiate restano immobili. Il capo volto verso la luce come in attesa di qualcosa che non pare giungere mai.
– Una mosca.
– Da dove è sbucata?
– Dalla finestra.
– Dal mondo là fuori?
– Ma allora esiste un mondo là fuori?
– O forse esiste solo questa mosca.
– Ultima testimone di un mondo là fuori scomparso?
– O forse mai esistito.
Le quattro voci si rimbalzano, l’una sembra sbattere contro la precedente e finire cruenta contro la successiva. Non sembra esserci comunicazione. Monologhi alternati, scansati, l’un con l’altro.
– Perché è finita in questa stanza?
– Perché esiste solo questa stanza.
– No. È una Loro messaggera. Ha un messaggio per noi.
– E che ci vuole comunicare?
– E come? Tu capisci il suo orrendo ronzio?
– Ma non lo sentite? Ascoltate? E’ chiaro!
– Cosa? Diamine cosa!
Il tono della donna si fa aspro. Sembra stanca di questa costante incapacità di comprendere le altre parole. Di dar senso a ciò che ogni giorno ascolta. Neppure il suono fastidioso della mosca che si fa progressivamente più intenso. Violento.
– Ascoltate come si ripete. E’ un codice.
– Un codice?
– Ha ragione. Anche io lo sento.
– Io non sento nulla!
Delusione. La voce della donna si affievolisce, sino quasi a spegnersi nello sconforto del non sentire. Del non comprendere. Tristezza nel vedere la ragazza sperare. Nel sognare le folli illusioni dell’uomo con la sigaretta. E il vecchio tace. Indifferente.
– Ascolta.
– Il ritmo. Si, lo sento. Ma sei sicura di non sentirlo anche tu?
– Acceso. Spento. Ronzio. Silenzio.
– Un codice. Semplice.
– Binario.
– E che cosa dice questo diavolo di codice? Che ti dice di tanto importante il brusio della mosca?
– Non lo. Ancora non lo so.
– Dobbiamo interpretarlo.
– Smettila tu di dire fesserie.
– Lasciala parlare!
– Ora sei tu a difenderla?
– Hanno ragione. Ci sta dicendo qualcosa.
Il vecchio. La sua voce stanca risuona nella stanza come un liquido denso, caldo che si espande, occupando gli spazi, e possedendo gli oggetti.
L’autorità è nel timbro, nella sicurezza con cui i suoni escono dalla sua bocca grinzosa.
– Anche tu lo senti?
– Si.
– Capisci cosa ci sta dicendo?
– Sono Loro, vero? Ci stanno comunicando che stanno arrivando?
– Siamo salvi?!
– No. Non sono Loro.
– Ma…?
– Allora noi…
– Che cazzo ci sta dicendo?
E’ la prima volta. La donna si scrolla di dosso la sensazione opprimente della saggezza, dell’autorevolezza del vecchio e reagisce. Si oppone. Si ribella ad un gioco delle parti in cui ogni ruolo è già deciso. E con il ruolo le parole, i gesti, i comportamenti. Lei si ribella al suo essere un figura di una trama già scritta. Come un personaggio che sul palco si oppone, rifiuta le battute e decide di essere vivo. Scomparendo oltre il sipario. Libero dal destino impostogli dal drammaturgo. Urlando contro di esso tutto il suo odio per la condanna ad una vita ripetuta, eternamente identica a se stessa, nelle colpe e negli errori. Grida l’illusione di poter non sbagliare e di non poter agire diversamente. Di non poter imparare.
E di non poter trovare il perdono per i gesti passati.
– Te lo ripeto. Che cazzo stai dicendo?
Il vecchio tace a lungo. Ha sentito nella voce della donna la ribellione. La punta di una lancia invisibile diretta non solo contro di lui ma contro tutto il resto: gli altri seduti alle poltrone, la stanza, il buio e forse anche qualcosa d’altro. Di indefinito. D’oltre.
– La mosca ci sta dicendo qualcosa.
– E cosa?
– Non ascoltarla. Ma guardala.
– La vedo. Vola intorno alla lampadina.
– Esatto. Osservala attentamente. Guarda come si avvicina lentamente. Gira intorno alla luce. E ogni cerchio è sempre più prossimo alla lampadina. Inesorabilmente.
– Si.
– Dove vuole arrivare la mosca?
– A me lo chiedi?
– A te. A voi.
– Alla luce.
– Alla lampadina.
– E ci arriverà?
– Smettila con queste domande del cazzo! Dicci che cosa ti sta dicendo quella fottuta mosca!
La ribellione della donna è nelle parole. Nell’uso violento dei termini. Falsa impressione di forza per mascherare debolezza. E paura. Infinita paura.
– Come vuoi. Guarda tu stessa.
Il vecchio alza il braccio sinistro, un gesto lento, svogliato. Come se non volesse più giocare un gioco in cui le regole e i ruoli sono scomparsi. Persi nella rivolta.
La donna osserva. L’uomo che fuma osserva e così la fanciulla. Osservano la mosca.
I cerchi si fanno sempre più stretti. I ronzi più insistenti. Più frenetici. Vi è ansia in quel suono fastidioso? Speranza?
La mosca è a ridosso della luce. Sembra sfiorare la superficie trasparente e luminosa della lampadina.
La superficie incandescente della lampadina.
E’ un attimo. Il cerchio si è fatto troppo stretto, troppo chiuso e la mosca si appoggia sul vetro della lampadina. E’ arrivata? E’ così giunta alla luce? Alla verità? Alla salvezza finale?
Ci resta appoggiata un attimo.
Nel bagliore accecante gli occhi delle quattro figure sedute non riescono a scorgere la mosca. Ma sanno che è nella luce. Lo sanno perché non sentono più il ronzio fastidioso. Né scorgono più il momento circolare. E poi succede.
Un ultimo ronzio. Più alto. Più acuto. Ma con un tono diverso. Non aggressivo. Triste. O forse disperato.
E la mosca cade. A terra. Attraversa l’alone d luce e scompare nel buio. Persa chissà dove sul pavimento incrostato e sporco di mille passi perduti. Un brusio sembra accompagnare la sua caduta ma è solo impressione. O un ricordo.
E il silenzio torna.
E la luce resta appesa. Là in alto. Lontana.
Mortale.
– Ecco cosa aveva da dirci la mosca.
Nessuno replica al vecchio. Fallite le rivolte. Fallita la ribellione dei personaggi condannati a scelte non proprie. E tutto resta identico. L’autorevolezza. La sottomissione.
I ruoli restano gli stessi. Ora. Prima e dopo. Conformemente ripetuti.
Semplicemente eterni.
Mortali.
Il tavolo. Tre bicchieri appoggiati. Una sigaretta e un rivolo di fumo che sale lento verso l’alto. Annebbiato l’alone di luce di una semplice lampadina pende dal soffitto macchiato e grigio. Uno strano odore nell’aria invernale. Tabacco mischiato al profumo di un liquore cattivo e sudore. Odore di esseri umani: secrezioni inconfessate, purulente emanazioni, fecali scorie. Ed altro. Un fragranza segreta. Che fa paura. Un sapore dolciastro, caramelloso, malignamente invitante. L’aroma della morte. Della sua ancella. Della Malattia. Ristagna tutt’intorno e impudico si mostra. E’ un amalgama indistinto che permea le quattro figure silenziose scomposte sulle poltrone spaiate. I volti oscurati dal buio perenne di una stanza mal illuminata. Tacciono e osservano il tempo scorrere pesantemente in avanti, maledettamente uguale a se stesso. Ad ogni respiro torna l’identico momento che si ripete, e l’odore. E la Malattia.
– Non sentite anche voi qualcosa?
– No. Non mi sembra.
– Tacete un momento. Ecco! Sentite?
– Forse…
– Sembrerebbe…
Una voce. Nella stanza improvvisa giunge una voce. Una nuova voce. Metallica. Impossibile distinguerne il timbro, il tono. E’ di donna? Di uomo? Sembrerebbe di entrambi. O di nessuno dei due. Come provenisse da un essere ancora indifferenziato. Antico. Androgina è la voce che è apparsa nella stanza. Antecedente ad ogni definizione di genere. Maschile e femminile al tempo stesso.
– Una voce.
– Viene di là!
– No. A me sembra più dall’altra parte.
– Maledetto buio!
– Accendete le altri luci!!!
– Loro non ti ascolteranno mai.
– Che si fottano i tuoi Loro!
– Chi è là? Fatti vedere! Vieni fuori!
– Non c’è nessuno là in fondo.
– E la voce?
– Zitti! Fatemi sentire!
Per una manciata di minuti le quattro figure languidamente stese sulle poltrone se ne stanno in silenzio cercando di catturare il mormorio che viene dal buio. E le parole. Confuse.
– E’ una radio.
– Si. Sembrerebbe una radio.
– Chi l’ha messa lì?
– Chi l’ha accesa?
– Per quale motivo?
– Perché ora?
La voce metallica e androgina continua a parlare ma le sue parole non si distinguono. Come un odore si fondono e si perdono nelle altre parole strillate dalle quattro figure sedute sulle poltrone. In un impasto sfocato. Denso.
– Fate silenzio! Non volete sentire cosa dice?
– Non dice nulla.
– Frasi gettate a caso qua e là.
– Lasciala parlare. Che importa?
– Ha ragione lui. Non facciamoci caso.
– Ma potrebbe dirci qualcosa del mondo di fuori. Degli altri.
– Non esistono gli altri!
– Che vuoi che ci interessi degli altri. Ci siamo solo noi ora.
– E Loro.
Non si agitano le figure sulle poltrone. Indifferenti alla voce androgina e metallica. Come se non avesse nulla da dire. Come se fosse poca cosa. Inutile.
Solo la donna sembra curiosa. Tende il corpo, quasi a catturare le parole, una ad una per dar loro senso. Per comprendere il significato e dare una ragione.
Persino il vecchio sembra non voler ascoltare la voce improvvisa della radio. Che già ne conosca il contenuto?
– Fatemi sentire, vi prego.
– Ma cosa vuoi che dica?
– Sono solo parole.
– Hanno ragione. Non ascoltare. Non prestar attenzione a quelle frasi. Tra poco finiranno.
– No! Io voglio sapere. Voglio ascoltare.
– Non c’è nulla da sapere.
– Si è quasi già spenta.
– Manca poco.
– Vi prego. Tacete. Fatemi ascoltare.
– Bla. Bla. Bla. Bla.
– No. Noi non vogliamo sentire quelle parole. Quindi non le ascolterai neppure tu.
– Non essere curiosa. Ti prego non esserlo.
E la voce della radio si affievolisce. Lentamente. E si spegne. Così come è comparsa svanisce. Nel nero di un angolo imprecisato della stanza buia. Muore il suono metallico e androgino. E il silenzio risorge. Protettivo. Opprimente.
– Si è spenta.
– Bastardi! Bastardi!
– Torna a dormire. L’hai sognata.
– No. Non l’ha sognata. Era lì. Ma non era per noi.
Sono sempre le parole del vecchio a porre il velo della fine. Conosce forse il momento in cui si giunge alla soglia dell’oltre. E serve così tacere. Fedele al suo ruolo. Ubbidiente alla trama.
– Bastardi!
La donna, le mani tra i capelli, il viso rigato da lacrime salate di frustrazione. Di disperazione. Di insensatezza. Mugugna insulti che non sono rivolti a nessuno. O contro se stessa. Fiele tra le labbra, nella bocca e nel naso l’odore, l’aroma indefinito di sudore, tabacco, liquore. E morte. Singhiozzi di un pianto per cui non vi sono lacrime.
– Bastardi!
L’identico momento. Nell’angolo la radio continua incessante a ripetere le stesse parole, ciclica ripetizione di poche frasi troppo debolmente sussurrate per essere ascoltate. Esaurita è la batteria che alimenta i circuiti ossidati, inutili i suoi rantoli finali, i vani tentativi di urlare le sua fine e con essa di trasmettere il messaggio, dando senso alla sua stessa esistenza. Non condannandola al fallimento. Ma nessuno ode le parole. Che nel freddo buio si perdono e avvizziscono. Fallimento.
– Trasmettiamo da…
– Qui Radio Libera Albemuth…
– La Malattia è ovunque.
– Questo è un messaggio registrato, il giorno…
– In automatico è ripetuto…
– Identico…
– Pochi sopravvissuti…
– Macchie nere ovunque…
– Morti. Morti. Morti.
– Secondo le stime…
– Sull’isola di…
– In una stanza…
– Resteranno…
– Gli ultimi…
– Quattro…
– Supersiti…
– Razza umana…
– Soli e…
– Condannati…
– Condannati.
La stanza è flebilmente illuminata, una lampadina pende dal soffitto scrostato tingendo di luce un poco dello spazio intorno. Un leggero bagliore che non rischiara gli oggetti, perpetuamente ammantati dal velo nero di un buio testardo, più forte di ogni luminosa ribellione.
Un piccolo tavolo quadrato se ne sta al centro della stanza, la superficie lucida sembra riflettere il tenue chiarore della lampadina, ma forse è solo un’impressione. Tre bicchieri vuoti sono lì poggiati e a un lato un posacenere, traboccante sigarette spente e fredde. Ormai fumate.
L’aria intorno è calda, un tepore sonnolento, avvolgente. Il caldo di una primavera che lentamente si sta trasformando in un’estate afosa, appiccicosa, sudaticcia. Nessun odore di fiori o di piante germogliate, ma solo il puzzo di vecchio, di stantio. E di altro. Dolciastro. Zuccheroso. Vago.
Intorno al tavolo quattro poltrone, scompaginate, sporche.
Vuote.
C’è silenzio nella stanza. Un silenzio languido, che pare distendersi sugli oggetti, inghiottendoli, avvolgendoli in una bolla priva di suoni. Ogni cosa resta immobile. Cristallizzata in un momento, statico. Eterno.
Nessun movimento, neppure un rivolo di vento agita la polvere depositata sul pavimento sporco e macchiato. Nessuna impronta, nessuna traccia di vite antiche. Resta solo la stanza, il tavolo e le poltrone. E forse un ricordo.
Un accendino pende dal bordo di un bracciolo della poltrona di pelle. Sfregiata, tagliata, come punita, massacrata per una crimine mai commesso. L’accendino se ne sta così, in un equilibrio instabile, messo lì apposta. In piedi. In attesa di un alito di vento che lo smuova. E a terra lo faccia cadere. Ma nessuna brezza. Nessun movimento.
E rimane lì, immobile, solitario. Ad aspettare ciò che mai giungerà. Inutilmente.
E il silenzio continua a regnare nella stanza.
(Questo racconto è stato scritto ascoltando l’album “Black Rain” di Ozzy Osbourne”)
Racconto pubblicato nell’antologia “Frammenti di una rosa quantica” – Kipple Officina Libraria, 2008.

Alex Tonelli è nato in riva all’Adda nel 1977 e si è laureato in Filosofia a Milano con una tesi contro il libero arbitrio. Connettivista da sempre, ha curato la rubrica Ermetica Ermenuetica sul bollettino del Movimento NeXT e la raccolta di poeti connettivisti “Concetti Spaziali, Oltre” (Kipple Officina Libraria). È presente nelle antologie “Frammenti di una Rosa Quantica” (Kipple Officina Libraria), “Nuove Eterotopie” (Delos Libri) e “La prima frontiera” (Kipple Officina Libraria) e dal 2015 è il curatore della collana di poesia VersiGuasti per la Kipple Officina Libraria. Ha pubblicato una silloge di poesie dal titolo “Oltremuro” (Kipple Officina Libraria). Attualmente vive a Trieste.