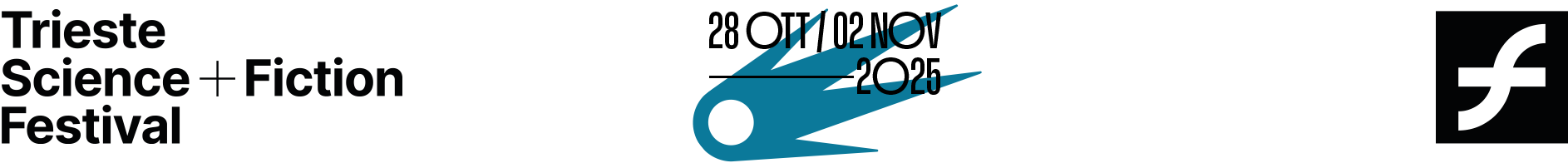La consapevolezza del supereroe
di Marco Catenacci
Ebbene si, anche i supereroi hanno paura. Paura di morire, paura di non farcela, paura di non essere più all’altezza. Paura di non riuscire a domare il Male, di non servire più a nulla. Paura di essere diventati, tutto ad un tratto, impotenti. L’elemento più importante di questo nuovo capitolo dell’universo Marvel, è quello di aver portato la figura del supereroe ad un diverso livello di consapevolezza (di sé, degli altri, del proprio ruolo). Una consapevolezza, che se nel primo The Avengers serviva soprattutto a creare situazioni di una comicità brillante e genuina, qui si fa più interiore ed intimista, cupa e a tratti quasi apocalittica.

Nel 2012 ci si poteva ancora permettere di scherzare con il super cattivo di turno, si poteva ironizzare sulla sua inevitabile sconfitta, si poteva ridere mentre lo si prendeva a pugni o lo si sballottava di qua e di là, in nome di una vittoria del Bene mai messa in discussione (perché scritta all’interno delle regole stesse del genere e dell’universo di riferimento). Oggi, tre anni dopo, i tempi sono cambiati. I tempi esterni al cinema, certo (la costante percezione di un mondo che sta sprofondando nel caos), ma anche i tempi e l’immaginario prettamente cinematografico. Pochi mesi dopo l’uscita del primo The Avengers, il terzo capitolo della saga dedicata al Cavaliere Oscuro (The Dark Knight Rises, 2012) di Christopher Nolan, si era spinto talmente tanto in là da riuscire a mettere in scena la morte del supereroe, inteso come maschera e simbolo protettore. In quel film il Male era diventato così imponente, che per sconfiggerlo si era reso necessario il sacrificio supremo. Male e Bene avevano raggiunto lo stesso livello e la guerra per il futuro del mondo non poteva che concludersi con la distruzione di entrambe le forze in gioco. Certo, Batman appartiene a tutt’altro universo, per certi versi opposto a quello degli Avengers.

Il mondo della DC è cupo e oscuro almeno quanto quello Marvel è (era?) divertente e spensierato, ma il successo e la portata della trilogia di Nolan hanno fatto si che il Cavaliere Oscuro diventasse immediatamente il nuovo termine di paragone per tutto il cinema dei supereroi. La conclusione della saga su Batman, assieme all’inedito livello di consapevolezza e brillante profondità raggiunto con il primo film dedicato agli Avengers, hanno fatto in modo che la cosiddetta “Fase Due” del Marvel Cinematic Universe, fosse permeata, a tratti, di una serietà e di una cupezza che non si erano mai viste in quel mondo (eccezion fatta per I Guardiani della Galassia di James Gunn, capitolo momentaneamente a parte in questa avventura). Esemplari in questo senso, sono Iron Man 3 (2013, il primo film della “Fase Due”) e soprattutto Captain America: The Winter Soldier (2014), nei quali, a ben vedere, viene messo in scena un processo di “morte del supereroe” (inteso ancora come simbolo) simile a quello costruito da Nolan, anche se privo della sua portata tragica e melodrammatica. In Iron Man 3 si continua ad insistere sulla crisi interiore dell’eroe, sullo stress post traumatico causato dagli eventi di New York narrati in The Avengers, che cela di fatto la sua paura di non essere più all’altezza della situazione. Nel finale infatti, si arriva all’autodistruzione di tutte le armature (il simbolo), in un pirotecnico festeggiamento per la vittoria, salvo poi, in ultima battuta (e proprio sulle macerie di quella che era stata la sua casa/laboratorio), rivendicare il proprio (super)ruolo: “Io sono Iron Man”. Una morte (apparente) che porta ad una rinascita.

Di ben altro spessore invece la morte messa in scena in Captain America: The Winter Soldier (il migliore e più cupo dei film dedicati ai singoli supereroi di questo universo), che passa attraverso più momenti significativi: il primo è il dettaglio dello scudo (oggetto/simbolo chiave della figura del supereroe in questione) lasciato cadere dall’Helicarrier durante il combattimento con il Soldato d’Inverno. Capitan America, proprio durante lo scontro finale, sembra arrendersi, si rifiuta di combattere contro il suo ex amico (ora trasformato dall’Hydra nel Soldato d’Inverno) e, dopo essersi tolto la maschera, rinuncia in un solo gesto alla sua arma, alla sua difesa e a parte del suo simbolo. Si lascia picchiare fin quasi a perdere i sensi, e l’enfasi data dal ralenti sul corpo del supereroe martoriato che cade dal mezzo volante dona alla sequenza una tragicità spesso estranea a questo universo. Tragicità che in questo senso prelude ad un altro momento significativo, ovvero il congedo del supereroe dal film. Capitan America (il simbolo, il supereroe) viene salvato dal Soldato d’Inverno e abbandonato privo di sensi su una spiaggia, con il costume distrutto e visibili ferite sul corpo. L’ultima immagine del supereroe che il film ci concede è quella di un corpo abbandonato in riva al mare. La sequenza finale ci mostra che Steve Rogers è vivo, ma mostra l’uomo.

Il simbolo, il costume (metaforicamente, il supereroe) è rimasto esanime sulla spiaggia. È un congedo che nulla ha a che vedere con le trionfanti e spensierate conclusioni dei precedenti film della Marvel e che prelude al tono molto più opprimente di questo nuovo cross over dedicato agli Avengers, che inserisce questo processo di morte subito all’inizio del film, come elemento portante sul quale costruire l’intera vicenda. Nella visione generata dalla gemella Maximoff, Iron Man (guarda caso, come si è visto sopra, il primo degli Avengers ad aver accusato una crisi interiore e ad essersi interrogato sul proprio ruolo) vede la morte dei supereroi. La morte dei Vendicatori, la morte del simbolo, la fine di un universo. È una visione che anticipa tutto il peso tragico del film e che pare rappresentare l’opprimente senso di responsabilità che attanaglia i supereroi, sempre più dubbiosi e incerti sull’esito finale della loro lotta contro il Male e sempre più insicuri del proprio ruolo in questo mondo. Se nel primo The Avengers si era giunti alla presa di coscienza del ruolo “super” dell’eroe, in questo caso la consapevolezza è di segno opposto: l’eroe sembra rendersi conto di non essere più così “super”. Direttamente da qui derivano allora la momentanea centralità data alla figura (e alla famiglia) di Occhio di Falco (il più “normale” del gruppo) e alla massa di civili, non più intesa come elemento di contorno, ma presa in considerazione come obiettivo primario della missione. Ecco cos’è che fa di Avengers: Age of Ultron un film radicalmente diverso dal suo predecessore; certo, anche qui si riceve una scarica di adrenalina durante le spettacolari battaglie, anche qui ci si esalta per la riuscita pirotecnica di combo memorabili, anche qui ci si diverte; ma con la consapevolezza sottocutanea del fatto che non c’è più nulla da ridere.

I supereroi sono in crisi, si sentono inadeguati a proteggere il mondo, commettono errori (Ultron stesso è di fatto uno sbaglio degli Avengers, nel tentativo di creare il programma definitivo di protezione del mondo) e sono costretti a creare altri supereroi (Visione) per scongiurare il pericolo. L’unità del gruppo è definitivamente minata: i supereroi adesso combattono da soli, ciascuno con le proprie responsabilità, i propri sensi di colpa, il proprio bisogno di (ri)affermarsi come componente centrale e necessaria; ciascuno, insomma, con le proprie paure. E ciò è evidente anche nel modo in cui Whedon ripropone il tanto osannato long take del primo The Avengers: se in quel caso l’inserimento di tutti i supereroi in una sola, vorticosa inquadratura stava a significare la ritrovata unità del gruppo, che finalmente stava combattendo come una squadra, in Age of Ultron il procedimento è speculare. Il long take viene inserito subito nei primi minuti del film, quasi a volersi ricollegare idealmente al finale ottimista e positivo del primo capitolo, per poi procedere alla disgregazione graduale del gruppo (Tony Stark e Bruce Banner agiscono spesso alle spalle degli altri, Thor ad un certo punto se ne va improvvisamente senza comunicare la sua meta, Hulk nel finale è disperso). Disgregazione, tra l’altro, che Whedon evidenzia in modo esemplare nel climax della battaglia finale, quando tutti gli Avengers si ritrovano a dover proteggere l’altare dalle centinaia di robot mossi da Ultron: laddove, nel film del 2012, il culmine della battaglia veniva risolto con un significativo long take, in questo caso la regia frammenta continuamente lo spazio con una serie di primi piani ravvicinati dei supereroi in combattimento. Non più una squadra, ma un insieme di individui, che combattono, tuttavia, per un duplice obiettivo comune: salvare il mondo e rivendicare il proprio (super)ruolo. Non è più il tempo di quel “Vendicatori Uniti!” che è da sempre, nel fumetto, il grido di battaglia degli Avengers. All’appello “Vendicatori…”, adesso, segue solo il nero dei titoli di coda.