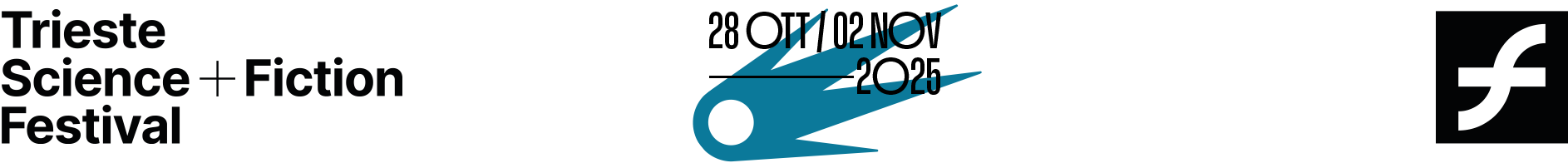Capo in B di Zeno Sarracino
Hashtur rovistava nella spazzatura con il tentacolo destro, mentre il sinistro grattava la palpebra dell’unico occhio nella protuberanza del capo. Liberò dalla polvere un pezzo di lamiera rosso, triangolare, ricoperto di ruggine: il grande occhio di Hashtur lacrimò nel mettere a fuoco le parole sul cartello.
– STOP –
La bocca, collocata nell’inguine, pronunciò l’arcana parola con suoni gutturali.
Hashtur si domandò, mentre continuava a strofinarsi la palpebra, quale significato avesse potuto avere quel misterioso oggetto. Uno strumento cerimoniale, forse? Osservò i contorni del cartello.
La forma triangolare echeggiava un significato nascosto, carico di minaccia, e altrettanto quel colore bianco su sfondo rosso, così vibrante nonostante i secoli. I resti di un’asta grigia, un tempo fissata nel cemento, protrudevano dalla lamiera.
– Adad! –
Si girò verso il compagno, gracidando dal ventre.
Adad rispose al saluto agitando entrambi i tentacoli.
Ancora un ragazzo, si rimproverò Hashtur, appena cent’anni di età.
Si trascinava con il corpo oblungo, dalla forma di una lumaca abissale, recante i colori biancastri della giovinezza. La bocca inguinale digrignò una triplice corona di denti a rostro, quando iniziò ad arrampicarsi sul cumulo di rottami. Le ventose dei tentacoli aderivano con soffici plop alle macerie. Intanto, il grande occhio di Hashtur ruotava a trecentosessanta, contemplando il paesaggio.
Una landa desolata, pensò, ma non priva di bellezza.
Un mare di rifiuti si estendeva all’orizzonte: dalle profondità sottomarine colme di barili tossici, correnti di tegole e legname nuotavano verso la superficie, spumeggiando con creste di rigonfi sacchi di plastica. La fusoliera malridotta di un Airbus A430 affogava nel ciarpame, le ali spezzate. Qua e là scogli e isole di cemento affioravano nel mare di spazzatura: ciclopici macigni, barriere coralline di stracci e cavi elettrici, scheletriche ossa di ferro con ancora una carne di calcinacci.
Il corpo di Hashtur si gonfiò dalla contentezza, di fronte a quello spettacolo: la pupilla nera dell’occhio si dilatava e restringeva man mano che zoomava su ogni singolo particolare. I lineamenti irriconoscibili, cancellati fino a raggiungere un’impossibile levigatezza, di due figure umanoidi, abbattute a fianco di una struttura a ogiva, che Hashtur riconobbe come una campana. Una fila di panchine di ferro, contorte e fuse, spiaggiate ai piedi della collina dove si trovava. Le ossa degli antichi occupanti ancora brillavano, incastonate da un inconcepibile calore nella struttura stessa dei manufatti. Hashtur guardò ancora, sollevando la protuberanza del capo fino all’orizzonte lontano.
Il mare di ciarpame si asciugava diversi chilometri avanti, divorato da una sabbia cristallina, dalla consistenza del vetro. Un pavimento di mattoni boccheggiava nella sabbia, proteso verso l’esterno. La chierica di una bitta, di ottone lucido, rifletteva la luce della stella.
Sole, rimembrò Hashtur, qui lo chiamano Sole. Non di meno, concesse, quella sorta di approdo proteso verso il deserto, un molo quasi, così lungo e solitario, era qualcosa d’inedito, pure in quell’infernale collezione di anticaglie. Audace, niente da dire, concesse Hashtur.
Un ansito e il risucchio di un tentacolo che si staccava dal cemento annunciarono l’arrivo di Adad. Aveva l’occhio socchiuso, costellato di striature rosse.
– Allora? – mugugnò – Ci è rimasto poco tempo a disposizione, come sai bene. I Padroni vogliono una risposta e subito. –
Hashtur curvò la protuberanza e con una lenta torsione afferrò con i due tentacoli un oggetto rotondo, dalle dimensioni di un palloncino. La bocca di Adad esalò un sospiro, mentre l’occhio si colorava di stupore.
– È meraviglioso – balbettò – Non sapevo potesse esistere qualcosa d’una simile bellezza –
– Tanto bello quanto prezioso – concordò Hashtur. Alzò l’oggetto a livello dell’occhio.
I denti ghignanti di un teschio ricambiarono spenti lo sguardo di Hashtur. Questi contemplò il giallo dell’avorio e gli occhi putridi dello scheletro, prima di riporre il reperto dentro una scarsella legata alla cinta.
– Siamo sulla strada giusta – sottolineò, indicando il cartello. – Ho anche trovato quell’oggetto cerimoniale, senza dubbio parte del loro culto. Dobbiamo solo continuare a scavare. –
Mentre Adad si arrabattava tra i rottami, Hashtur si concesse di controllare l’astronave. Aleggiava sopra il molo invaso dalla sabbia, la sagoma luminescente nella forma di una balena. I microrganismi responsabili dell’energia nucleare della nave emanavano un impercettibile brillio, reminescente di un miraggio. Hashtur sentì qualcosa sfrecciargli davanti, si piegò di scatto: uno dei tentacoli saettò in avanti, stringendo per la collottola un animale ringhiante. Era tutto un batuffolo: una coda serpeggiava avanti e indietro, degli unghioni e due triangolini a mo’ di orecchie. In mezzo a tutti quei magnifici rottami, contaminati e morti da secoli, quella presenza viva disgustava profondamente Hashtur. Contaminava, con la sua vitalità selvaggia, la purezza artificiale del luogo. Con uno schiocco come di un elastico che si rompe, mutilò in due il gatto selvatico, ne afferrò la testa dagli occhietti che ancora sbattevano e la divorò in un sol boccone. Secoli di contaminazione radioattiva e ancora così tanta vita, così tanta natura… deprimente, pensò, consolandosi con il ruminare degli ossicini del micio.
Il rimbombo di un tuono, lo stridio di una tonnellata di sassi in movimento e infine un urlo sottile: Hastur si voltò, solo per vedere Adad scivolare strillando in un crepaccio. Le grida del giovane perforarono le membrane acustiche di Hashtur, mentre si avvicinava con cautela alla fossa che si era spalancata nella collina. Un cartellone di diversi metri, raffigurante una figura umanoide che trangugiava una sostanza, giaceva in un angolo. Hashtur la guardò sbattendo l’occhio, riconoscendovi un’altra sacra icona. Un rituale di morte, forse, suggellato da quel “Coca Cola” inciso a lettere gigantesche. Probabilmente l’umanoide beveva il sangue dei suoi nemici nelle speciali occasioni, per assimilarne la potenza. Un avviso, ignorato dall’incauto Adad.
Svelato dal cartellone, un pavimento di vetro, ora infranto. Un pozzo di cartacce e sacchi di plastica si spalancava nel fianco della collina, scendendo nelle profondità di quel mare di spazzatura. Hashtur sospirò, scuotendo la protuberanza, poi afferrò dalla scarsella un organismo-torcia, lo strizzò per farlo impaurire e fargli secernere la luminescenza necessaria. Lo gettò nel pozzo, guardando la luce penetrare l’oscurità sottostante. Le pareti del pozzo sembravano solide e il fondo non era troppo distante, a giudicare dai singhiozzi ingrati di Adad.
Un tentacolo alla volta, Hashtur discese nell’oscurità.
Una fanghiglia terrosa caratterizzava il fondo del pozzo. Hashtur strizzò un altro organismo-torcia, prima di fargli mordere la sua spalla, affinché funzionasse da illuminazione portatile e gli lasciasse liberi i tentacoli. A diverse decine di metri dalla superficie, il pozzo rivelava un rozzo edificio di pietra. Hashtur si guardò intorno: bacheche di legno, con i vetri infranti, un mobile di plastica ingombro di carta e una tinozza piena di terra. Hashtur si avvicinò prima alle bacheche, ammirando all’interno una serie di oggetti di legno e ferro. Mazze e spade, lesse da un cartiglio della bacheca. Erano molto belle, rimuginò, anche se non riusciva a comprenderne l’utilità. Strumenti per mangiare o forse per riprodursi o addirittura per grattarsi la protuberanza. Innocui: poco, ma sicuro.
Il mobiletto di plastica aveva diversi cassetti. Ci armeggiò per qualche minuto, prima di farne scaturire un rivolo di carta. Erano pezzi di carta verdi, tutti eguali, con sopra un numero. Hashtur rinunciò a comprenderne l’utilizzo: sembravano buoni per la pulizia corporale, con il numero corrispondente alla grandezza del pezzo. Cinquanta di quegli “euro” quando sei davvero sporco, venti quando hai meno da espellere e così via.
La tinozza era piena di terra e ospitava, coltivati in fila, diversi funghi luminescenti. Una paletta giaceva a lato della vasca, ancora fresca di terra. I funghi erano cresciuti da poco, osservo Hashtur. Qui ci vive ancora qualcuno! E Adad, dov’è finito? Maledetto sciagurato…
Lo trovò accucciato dietro la carcassa di un’automobile.
– Tutto bene… Come diamine hai fatto… –
Adad lo azzittì con un colpo di tentacolo, ne avvicinò la punta alla bocca. Indicò qualcosa dietro ad Hashtur, gesticolando. Hashtur si volse con lentezza deliberata. Sentiva la bocca digrignare e agitarsi, il corpo cambiare colore dalla tensione. Hashtur represse il fremito nei tentacoli, sbatté la palpebra dell’occhio. Si preparò a fronteggiare il terrore assoluto che aveva cacciato Adad nelle tenebre.
E scoppiò a ridere, ogni tensione svanita.
– Hai paura di lui, Adad? Un essere così insignificante, così piccolo… –
Hashtur riconobbe dal cranio il profilo di un umanoide: due occhi catarrosi, quell’appendice chiamata naso, la bocca minuscola, il corpo sgraziato. Una gran massa di pelo copriva la faccia dell’essere, dai capelli alla barba, mentre un torace emaciato mascherava le ossa, protese sotto una pelle raggrinzita, colorata del rosso di ustioni cicatrizzate. Un lembo di tessuto copriva le terga, a cui seguivano gambe dalle ginocchia calcificate a causa dei calli e grossi piedi ritorti.
Hashtur osservò l’uomo avanzare gattoni, prima di accucciarsi e abbaiare una serie d’incomprensibili suoni. Le mani che si agitavano e i guaiti continui stremavano lo sguardo, osservò Hashtur, concedendo qualche punto al collega. Ma quella cosa chiamata “uomo” restava un affarino minuscolo, neanche due metri di altezza rispetto ai suoi cinque. Un povero essere, nemmeno in grado di cambiare il colore della pelle a seconda dell’emozione e del messaggio che voleva trasmettere. Probabilmente è proprio per questo motivo, meditò Hashtur, che sente il bisogno di parlare e gesticolare così tanto.
Cosa diamine era quel gesto con l’indice della mano puntata verso la bocca?
Si avvicinò all’umanoide con movimenti lenti. La bocca era un baratro di gengive infiammate e monconi marci. Hashtur riconobbe dall’esperienza con i microrganismi sulla nave le ustioni derivanti dalle radiazioni nucleari, rimarginatosi dopo decenni.
Quel gesto… cosa accidenti desiderava quello stupido animale?
Analizzò la tinozza e i resti dei funghi smangiati lungo il bordo. Hashtur aprì allora la scarsella e pescò un altro piccolo organismo, modellato a forma di cilindro. Lo massaggiò affinché secernesse il suo liquido, del quale assaggiò una sorsata rivitalizzante. L’offrì avvolto nel tentacolo all’uomo, che indietreggiò mugolando. Il selvaggio aveva gli occhi sbarrati, le braccia incrociate sul petto: sbaglio qualcosa, rifletté Hashtur, non è questo il modo corretto.
Strisciò verso le bacheche, alla ricerca di un contenitore. Lesse dal cartiglio: tazza di porcellana, era Ming. Massaggiò l’organismo fino a riempire la tazzina, la offrì all’uomo.
Quel barbaro animale gettò subito a terra la tazza, la infranse in mille pezzi! Quale spreco, sbraitò tra se e se Hashtur, tutto quel liquido l’avrebbe come minimo tenuto sveglio un’intera notte. Il meglio delle sue scorte, nientemeno.
L’umanoide continuava a gesticolare, con quell’indice puntato verso la bocca e quel mugolio continuo. Hashtur provò un’altra tazzina, solo per vederla infranta. Tentò una tazza grande, una tazzina piccola, una tazza di colore diverso, una tazza di plastica dal mobile…
Un servizio da te giaceva distrutto sul pavimento. Hashtur brontolò, valutò se spaccare il collo all’uomo. Adad gli picchiettò sulla protuberanza con un tentacolo, gli porse un nuovo contenitore. Era simile alle “tazzine”, ma dalla forma semplice: un cilindro corto e basso, composto di vetro. Ci versò le ultime riserve della sostanza, riempiendolo fino all’orlo. L’animaletto espulse fino all’ultima goccia il liquido nero pece, prima di secernere con le ultime forze uno strato bianco. Hashtur propose quella prelibatezza all’uomo, sospirando.
Il selvaggio dilatò gli occhi, batté il palmo della mano contro il pugno, sorridendo. Si sedette a gambe incrociate, afferrò con mignolo sollevato il bicchiere e assaporò la bevanda. Si leccò i baffi, prima di riprendere a gesticolare e sbraitare. Indicava ora il bicchiere, ora Hashtur. Questi gemette, non la smette proprio mai di parlare! e scosse la protuberanza, mostrando il piccolo organismo svuotato.
– Basta, basta! Non abbiamo altro liquido, ci arrivi o no? Niente. Più. Liquido. –
L’uomo continuava a indicare il bicchiere e accompagnava il gesto con tre parole. Hashtur si lambiccò la protuberanza, cercando di ricordare lingua e dialetti della razza umana, relativamente all’area dove si trovava. Riconobbe dopo qualche minuto la sillaba “B”.
Senza dubbio, rifletté, vuole trasmettermi un profondo ragionamento: un messaggio di pace, di fratellanza, di riconoscenza…
Adad era A, Hashtur era B. Quell’umano forse contava tramite l’alfabeto. Dopo mezz’ora e un lungo colloquio con Adad, Hashtur riconobbe la seconda parola, “Capo”. Capo come guida, padrone, essere superiore: quell’animale non poteva che riferirsi a lui, Hashtur. Quindi, ricapitolando: Hashtur era sceso nel pozzo subito dopo Adad ed era pertanto “B”, ma era anche il padrone, il “Capo”. Hashtur: “Capo in B”. Gonfiò il corpaccione, lusingato dal complimento.
Questo significa che non solo quest’umano è vivo e vegeto – ragionò Hashtur – ma persino nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e linguistiche, con tanto di lingua e dialetto della zona pienamente conservatesi dopo così tanti decenni di bombardamento radioattivo. In altre parole, qualcuno ancora abita questo colle e questo mare di spazzatura e infesta, come quell’animale catturato all’aperto, la bellezza sterile del paesaggio.
Afferrò come Adad dalla scarsella dell’altro cibo e liquido, che lasciò ai piedi dell’uomo, affinché non li disturbasse nella risalita e se ne restasse nel suo buco. Sulla cima del colle, Hashtur assaporò il vento denso di liquami, prima d’iniziare la lenta discesa verso l’astronave.
Hashtur si sentiva la protuberanza leggera e colorò il corpaccione di rosso dalla soddisfazione. Frugò nella scarsella fino a rinvenire un altro piccolo organismo dalla forma arcuata: dopo averlo strofinato alla testa, lo convinse ad allungare un’antenna.
Lo accostò alle membrane acustiche, controllò la ricezione.
– Pronto, pronto, mi senti? La ricerca è finita, prepara i motori. Io e Adad abbiamo verificato la presenza di esseri viventi e persino di un essere umano, ancora fermo alla famiglia sapiens sapiens. Sì, hai capito bene, ancora in grado di parlare e ragionare. Gli abbiamo lasciato del cibo. Pienamente d’accordo: un bombardamento planetario non è bastato, o tre testate nucleari su larga scala per cancellarne la presenza. Sono resistenti, questi umani. Un altro paio di secoli e forse si decideranno ad estinguersi. –
Hashtur accarezzò il cranio d’uomo nella scarsella, prima di dirigersi verso la rampa dell’astronave.

Zeno Saracino è nato a Trieste nel 1992.
Ha iniziato lo studio della storia locale all’Università di Trieste con una tesi triennale sulla rivoluzione del 1848 a Gorizia e ha approfondito la passione per la Mitteleuropa con una tesi magistrale in Storia dell’ebraismo sulla vita a Vienna dell’intellettuale Filippo Zamboni.
Negli anni ha lavorato con Italia Nostra nella salvaguardia del patrimonio di archeologia industriale del Porto Vecchio di Trieste. Collabora con le case editrici Watson Edizioni e Lettere Elettriche, mentre a livello giornalistico scrive per la testata Trieste All News.
Ha pubblicato nel 2018 il saggio “Trieste Asburgica: l’arte al servizio dell’industria” con centoParole edizioni. Lo studio della tesi magistrale è poi sfociato nel saggio “Filippo Zamboni: un repubblicano in Austria-Ungheria” edito da Quaderni Giuliani di Storia.